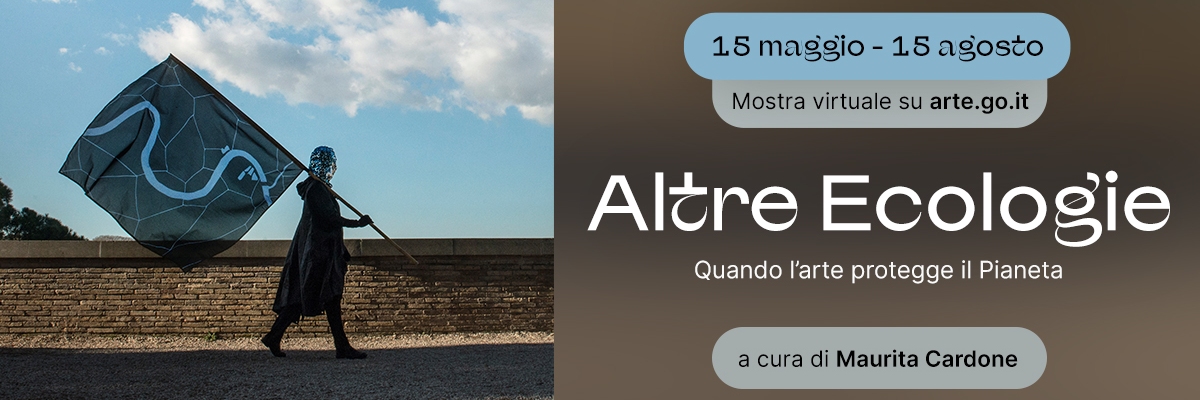Chi non conosce la miniatura potrebbe considerarla come pittura in scala ridotta, e come tale un’arte “minore”. Tanto è vero che il termine è usato per indicare, nei casi piu diversi, piccole dimensioni. In realtà “miniatura” deriva da “minio”, l’ossido di piombo, colore rosso vivo, usato sin dall’antichitr come colorante. Miniare quindi significa colorire di minio, cioc di rosso. La piu antica forma di decorazione libraria fu appunto la colorazione in rosso dei titoli e delle parti piu rilevanti del testo (gli indici, le lettere iniziali dei capitoli, ecc.).
Solo successivamente, dall’età alto medievale, il termine “miniare” giunse ad identificare la decorazione dipinta di un manoscritto, e la miniatura, strettamente legata alla parola scritta, iniziò a comparire all’interno degli oggetti nei quali la scrittura è conservata, cioè rotoli (volumina) e libri (codices).
Per lunghi secoli scrittura e miniatura furono praticate nei monasteri, luoghi preposti a conservare e tramandare i testi piu diversi, contemporanei e antichi, non solamente religiosi o liturgici ma anche poetici, scientifici, filosofici, astrologici, ecc.
Dal tardo medioevo, la pratica degli scriptores e dei miniatori si estese ai laici che servirono sia le comunità religiose, che abbisognavano di testi liturgici e di devozione, sia gli studiosi che amavano arricchire le loro biblioteche.
La protezione delle pagine miniate dalla luce e da altri agenti di usura consente, nei casi piu fortunati in cui i materiali si sono conservati integri, di tramandare fino a noi immagini di clamorosa freschezza e di intatto colore.
tratto dal Catalogo della mostra “Per Girolamo Dai Libri (1472–1555). Pittore e miniatore del Rinascimento veronese“
a cura di Gino Castiglioni, Paola Marini, Francesca Rossi. Catalogo Marsilio a cura di Gino Castiglioni con la collaborazione di Gianni Peretti
Periodo: 12 luglio 2008 – 15 febbraio 2009
Museo di Castelvecchio – Verona
Girolamo dai Libri
Figlio di Francesco Dai Libri, celebre miniatore veronese, e di Granata, Girolamo nacque a Verona nel 1474 circa.
I primi anni li passò a fare apprendistato, insieme al fratello Callisto (con il quale collaborerà), presso suo padre, che era molto apprezzato e conosciuto in tutto il territorio della Repubblica di Venezia.
Divenne così miniatore; oggi ci rimangono numerosi esempi della sua produzione miniatoria.
I primi committenti di Girolamo furono i padri olivetani della chiesa di Santa Maria in Organo, per i quali lavorava anche il padre; questi religiosi cominciarono a pagare il giovane artista in qualità di “fiolo de magistro Francesco miniador”.
Essendo veronese fu fondamentale per Girolamo come per tutti i pittori del tempo l’esempio della Pala di San Zeno di Andrea Mantegna, primo esempio di Rinascimento compiuto in Verona.
Nonostante Vasari, nella descrizione che fa di Girolamo e della sua opera, parli della sua prima opera pittorica eseguita a soli sedici anni, si è più propensi pensare che in realtà sia stata realizzata da Girolamo in età più avanzata.
L’opera è una Deposizione, eseguita su commissione della nobile famiglia veronese dei Da Lisca e posta sino al XVIII secolo sull’altare della famiglia nella chiesa di Santa Maria in Organo e spostata poi nella chiesa di Santo Stefano a Malcesine.
Si dice che i veronesi, vedendo la pala, dove è possibile notare sullo sfondo la città di Verona, siano andati a congratularsi presso Francesco per l’eccellente lavoro del figlio.
Altra importante opera giovanile di Girolamo, di subito posteriore alla Deposizione, è il Presepio dei conigli pala realizzata per la famiglia dei marchesi Maffei e posta di fronte alla Deposizione in Santa Maria in Organo (1500).
Negli anni immediatamente successivi al 1500, Girolamo sposò una donna, che morì poco dopo e della quale non si ha alcuna notizia, se non che diede al pittore due figli, Chiara (1507) e Francesco (1509).
Recenti studi hanno portato a pensare che la moglie del pittore sia morta a causa della peste che colpì Verona tra il 1510 e il 1512 in seguito alla guerra della Lega di Cambrai e alle disfatte veneziane.
Di questi anni è la realizzazione de I Santi Rocco, Sebastiano e Giobbe conservato nella chiesa di San Tomaso Cantuariense.
Girolamo tornò a sposarsi con una donna molto più giovane di lui, Cecilia, dalla quale ebbe tre figli, Zuan Paolo, Agnese, Granata.
In seguito agli sconvolgimenti della trascorsa guerra, i padri di Santa Maria in Organo decisero di rinnovare la loro chiesa e commissionarono ai due migliori pittori cittadini, Francesco Morone e Girolamo Dai Libri, la decorazione delle portelle del nuovo organo.
Secondo le testimonianze, i due maestri, grandi amici, lavorarono in perfetta sintonia e armonia, senza mai litigare e dividendosi il lavoro con equità.
Successive a questo lavoro di successo furono alcune delle maggiori opere di Girolamo, come la pala di San Leonardo e la Madonna con il Bambino e sant’Anna, oggi conservata alla National Gallery di Londra.
Importanti testimonianze attribuibili a Girolamo dai Libri come abile miniatore le troviamo in tre corali custoditi presso l’Abbazia di San Benedetto in Polirone di San Benedetto Po, due dei quali datati 1554 e 1555, recanti anche la firma Theodorus de Castrogofredo (Teodoro da Castel Goffredo), valente amanuense (scriptor) del tempo.
Il maestro si spense nel 1555 a Verona, dove aveva sempre vissuto e ottenuto grandi riconoscimenti.
Girolamo dai Libri. (15 giugno 2019). Wikipedia, L’enciclopedia libera. Tratto il 17 marzo 2020, 07:51 da //it.wikipedia.org/w/index.php?title=Girolamo_dai_Libri&oldid=105687353.