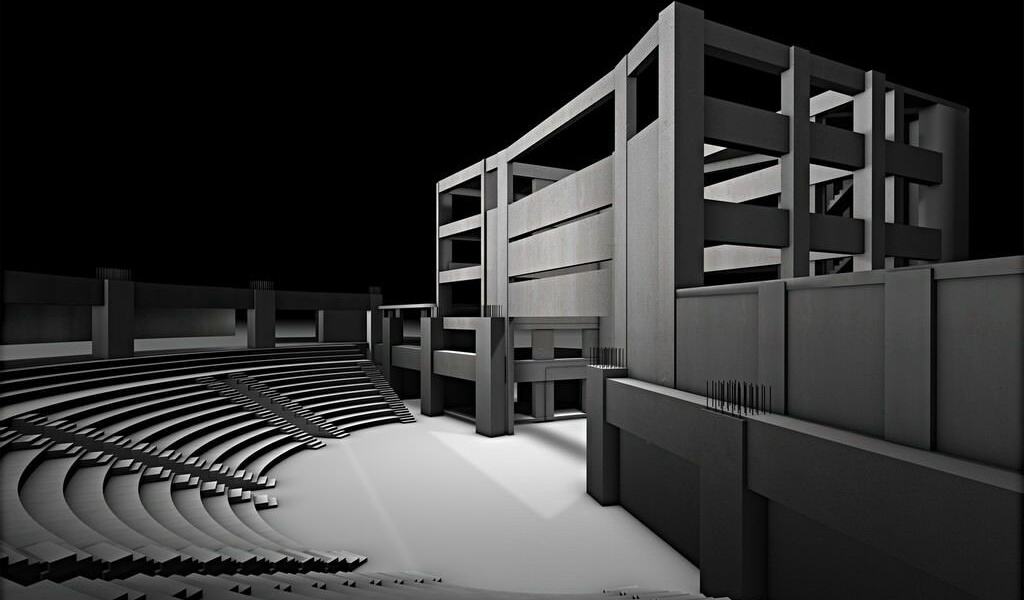
Ormai dei luoghi conosciamo tutto, come anche del loro stato negativo, avvisato dalla presenza dell’avverbio non, e da ultimo di quella loro presunta condizione superlativa, che nella nostra cultura indica una sorta di condizione di arrivo, che ha sostituito in questa funzione la gloriosa particella neo.
Nondimeno per le immagini possiamo affermare la stessa cosa.
Nessun mistero sembra infatti impedire al nostro sguardo di sondarne in profondità morfologia e senso. Se c’è una cosa che il nostro tempo ci ha insegnato a decifrare quotidianamente, essa è senza dubbio l’immagine. Si tratta evidentemente di una necessità, di una reazione dettata dall’istinto di sopravvivenza, in un ambiente che alle immagini ha destinato la quasi totalità delle proprie funzioni comunicative e di conoscenza.
Ma proprio in conseguenza di questo eccesso di analisi, di capacità percettiva e conseguente comprensione, entrambi, i luoghi e le immagini, come per paradosso continuano a riservarci delle domande, o meglio delle questioni, non sempre di facile risoluzione.
Le cause di questa ostinazione interrogativa, sono naturalmente legate alla nostra stessa mobilità evolutiva, a quei cambiamenti che assumiamo in conseguenza alla mutazione degli stessi luoghi e delle stesse immagini. Noi cambiamo perché loro cambiano, e loro cambiano perché noi cambiamo. Il classico serpente che si morde la coda. Un inseguimento logico e infinito, che è reso vieppiù complesso dalla coesistenza di diversi fattori in dialettica contraddizione. Innanzitutto la varietà delle immagini e dei linguaggi con cui vengono elaborate, a cui si aggiunge la coesistenza sul piano orizzontale di quella verticalità temporale che giustappone immagini del passato con quelle del presente, in una forma che è sempre più priva di soluzioni di continuità. Mentre per i luoghi una condizione equivalente è data dalla perdita di confini tra luoghi reali e luoghi virtuali, in una contaminazione tra i due che è governata proprio dalla capacità dell’immagine di divenire membrana permeabile tra le due condizioni.
Se si riflette con attenzione, la stessa definizione di nonluogo era debitrice di questa contiguità, che è poi diventata flagrante sovrapposizione.
Se rileggiamo alcuni passaggi essenziali del famoso “Nonluoghi” di Marc Augé, ci rendiamo conto che la loro definizione coincide con quella della trasformazione dei luoghi in una sorta di immagine astratta e stereotipata.
“Se un luogo può definirsi identitario, relazionale, storico, uno spazio che non può definirsi né identitario né relazionale né storico, definirà un nonluogo.” […] “Tuttavia, i nonluoghi rappresentano l’epoca; ne danno una misura quantificabile ricavata addizionando – con qualche conversione fra superficie, volume e distanza – le vie aeree, ferroviarie, autostradali e gli abitacoli mobili detti <> (aerei, treni, auto), gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e aerospaziali, le grandi catene alberghiere, le strutture per il tempo libero, i grandi spazi commerciali e, infine, la complessa matassa di reti cablate o senza fili che mobilitano lo spazio extraterrestre ai fini di una comunicazione così peculiare che spesso mette l’individuo in contatto solo con un’altra immagine di se stesso.”. (pagg. 73 e 74 dell’edizione Elèuthera del 1993).
Appunto. Un’altra immagine di se stessi. Ma, ancora prima, siamo di fronte ad un’immagine, pura e semplice, se così si può dire.
Questa identificazione dei luoghi, e delle sue declinazioni, con delle immagini, non comporta, contrariamente a quello che si potrebbe dedurre, la scomparsa della forza di gravità, cioè la perdita di quella condizione di realtà che pure continuano a portarsi dietro. Ma è la loro identità ad essere sottratta, ad essere smarrita in quel continuo trasformarsi in immagine e viceversa. In termini solo all’apparenza più banali, possiamo senz’altro dire che nel passaggio di un luogo alla sua immagine, e nella conseguente trasmissione nei canali mediali, le realtà dei luoghi tendono a sovrapporsi creando un’analogia, che è effettiva nel loro stato di immagine. I nonluoghi principiano proprio da questo stato delle cose, trovando non a caso la massima coincidenza in quelle situazioni pubbliche, intermedie e di transito. Ma è sempre più evidente che il processo riguarda sempre più i luoghi in senso esteso, soprattutto quelli che si vanno caratterizzando in conseguenza all’azione del nuovo costruire. Quelli cioè la cui identità è legata ad edifici e ambienti concepiti e prodotti oggi, che è tanto più forte proprio in quelle situazioni in cui si trovano direttamente a contatto con il passato, riducendone il carattere distintivo.
All’architettura dobbiamo quindi imputare essenzialmente cause e conseguenze di questo processo. E non potrebbe essere altrimenti, né questa è in assoluto una condizione di colpa. Piuttosto, e chiaramente, essa corrisponde alla condizione dei nuovi modelli sociali e della loro definizione in relazione a quella della dimensione individuale.
Come dice bene Ulrich Beck nel suo “La società del rischio” (Carocci editore, 2000), la concomitanza di fattori diversi, ma perfettamente simultanei, come sono quello della individualizzazione e della standardizzazione, che presuppongono una rafforzata dipendenza da istituzioni come il mercato, il diritto, la formazione, l’assistenza medica, la pianificazione del traffico, e così via, ha prodotto un nuovo tipo di isolamento e di standard di riferimento, che ha profondamente mutato la morfologia sociale e di conseguenza le necessità e la tipologia dell’ambiente in cui si è. A queste nuove esigenze corrisponde dunque l’architettura oggi, da cui consegue il carattere che hanno assunto i luoghi.
È difficilmente contestabile il carattere di “immagine” che ha assunto buona parte dell’architettura degli ultimi anni. Essa ha cioè per meglio dire elaborato un doppio ruolo all’interno del nostro ambiente. Se da una parte ha dovuto ovviamente mantenere una propria persistenza tridimensionale e di definizione dello spazio reale che occupa, dall’altra questo stesso aspetto è andato sempre più subordinandosi a quella condizione emblematica e immaginifica, che è veicolabile dai media sotto forma appunto di immagine. La diffusione globale dell’edificio, il suo divenire simbolo di comune appartenenza, e quindi identificabile come nuovo standard di consumo per tutti gli individui del mondo, è un dato essenziale e vitale per l’architettura di oggi, molto spesso più decisivo della stessa capacità funzionale e pertinenza alle ragioni per cui è stato progettato. È semplicemente secondario che ad esempio il nuovo edificio del Mit di Boston, realizzato da Frank Gehry, abbia dimostrato gravi inefficienze funzionali, così come sono passate in secondo piano le critiche ricevute da Santiago Calatrava per il suo teatro dell’opera a Valencia, o quelle fatte all’aeroporto di Osaka firmato da Renzo Piano, o ancora quelle ricevute da Daniel Libeskind per il progetto della Freedom Tower, che è stato più volte revisionato. Gli esempi in tal senso non mancano, ma appunto essi non intaccano l’immagine, intesa proprio nel senso letterale e nondimeno sostanziale, che questi edifici mantengono nel contesto del nostro ambiente. Per quanto essi siano nella realtà sbagliati, non funzionali o disarmonici rispetto al contesto, saranno infatti pochissimi quelli che ne verificheranno direttamente le incongruità, rispetto alla diffusione simbolica che quei luoghi, quegli edifici, avranno nel circuito mediatico, e che porterà di fatto alla definizione dell’immagine, e quindi della realtà, che tutti noi abbiamo del nostro ambiente.
In questa perfetta equivalenza tra immagine e realtà, ormai ampiamente definita, un ruolo decisamente anomalo, se lo è andato man mano ritagliando l’arte. Da essa ci saremmo infatti aspettata una condivisione di questa identità, a cui contribuire con un’ancora più esasperata supervalutazione dell’immagine, che spostasse con maggiore decisione l’asse dalla realtà a quest’ultima. Ma così non è stato. L’arte ha altrimenti deciso di mostrare i limiti dell’immagine, differenziandola dalla realtà e ottenendo per converso, o cercando di ottenere, che attraverso di essa il reale fosse osservato in quanto tale. Sembrerebbe una sorta di suicidio, invece questa inversione di tendenza, ha dato all’arte uno spazio espressivo improvvisamente nuovo e differente dal passato. Ma soprattutto le ha restituito un ruolo etico, che è diventato in maniera inedita il perno centrale del proprio operare.
Scelte apparentemente formali e linguistiche, come lavorare costantemente sul site specific, o eludere il valore emblematico nell’elaborazione delle proprie immagini, l’hanno infatti condotta ad una relazione strettissima con i luoghi e le condizioni che li definiscono. Ma nondimeno hanno permesso alle immagini di trovare sempre una specifica relazione con la realtà, non sostituendosi ad essa, ma siglandone la diversità.
Un’opera d’arte non potrà mai essere interpretata, come avviene per qualsiasi immagine elaborata per il circuito mediale, come una rappresentazione del reale, che assume su di se e meglio i caratteri di quello stesso reale. Essa sarà sempre invece intesa come uno sguardo caratterizzato su di esso, che si aggiunge a quel reale, costituendo esso stesso qualcosa di nuovo e di diverso, ma mai reversibile.
Quello sguardo ha infatti in se una condizione “critica” che non ammette un adeguamento supino, ma che impone all’osservatore di elaborare a sua volta uno sguardo e, naturalmente, una riflessione “critica”. Una modalità che trova la sua più eclatante conferma nell’ambito dei linguaggi del video e della fotografia, produttori per eccellenza di immagini.
Il lavoro degli artisti invitati a Zoom, ne rappresenta un esempio straordinariamente efficace. Ognuno di loro, e in modi diversi, effettua un’analisi fenomenologica della realtà, azzerando quella mutualità tra quest’ultima e la sua rappresentazione. Lo fanno in particolare, in quell’ambito di strette relazioni che ci sono tra i luoghi, le architetture, gli spazi abitativi, e l’uomo, ottenendo una condizione etico-narrativa che elude qualsiasi inganno.
Il lavoro “Concrete Island” ispirato all’Incompiuto Siciliano del gruppo Alterazioni video, è la dimostrazione immediata di questo atteggiamento. L’esemplificazione di come lo sguardo sulla realtà abbia possibilità critiche e capacità analitiche, e di come le immagini siano capaci di una presa diretta sulla realtà, pur rimanendo ben differenziate da quest’ultima. Questa specie d’indagine sul campo che mostra lo stato delle opere pubbliche rimaste incompiute nel territorio di Giarre, un piccolo paese in provincia di Catania, ha tutta la forza etica e la gravità di una denuncia che non è solo politica, ma che prima di tutto riguarda l’impegno del nostro sguardo a comprendere lo stato della realtà.
Qualcosa di analogo si avverte nella serie di fotografie di Paola De Pietri che vanno sotto il titolo “Qui di nuovo”. La relazione tra le figure delle donne, che tengono in braccio i propri figli, e l’ambiente urbano è talmente forte da stabilire una continuità di senso, una vera e propria dipendenza, che può essere definita come un’identità. Ma è l’elemento umano, che assume un tono simbolico assumendo un connotato sociale, a caratterizzare il paesaggio, l’ambiente. Un passaggio che intende così sottolineare il valore delle relazioni nella conoscenza del luogo.
Analogamente nel video “Too Much (Country)” di Domenico Mangano, il paesaggio urbano di un sobborgo degli Stati Uniti d’America è ugualmente, e in modo sincrono, definito tanto dalla tipologia architettonica che dai tipi umani che la abitano. L’indissolubilità di questi elementi forma quell’oggettività dello sguardo che è in grado di restituirci una fenomenologia della realtà attraverso l’immagine.
Rossella Biscotti compie un’operazione di osservazione e di lavoro sul reale che invece assume su di se delle potenzialità narrative e immaginative che amplificano in modo imprevedibile i dati della stessa realtà. Guardando il video “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”, dopo qualche minuto si ha la consapevolezza che quelle semplici azioni del costruire, del zappare la collinetta, di pulire la barca, non porteranno a delle conseguenze logiche. La provvisorietà della casetta, o quella collina che si anima di luci e musica, e ancora quella barchetta assurdamente impavesata di vele inutili, decidono di una surrealtà che si sovrappone a quella realtà che invece è dichiarata dal primo articolo della Costituzione italiana.
Qualcosa di analogo, nel senso di una sovrapposizione di surrealtà e realtà, senza soluzione di continuità, è ciò su cui lavora anche Guendalina Salini. Il video “L’uomo che non c’è non c’è che l’uomo” ne mostra quelli che possiamo definire i fondamentali: un uomo che attraversa la città con la testa infilata dentro un cubo fatto di specchi. Il suo volto, o meglio la sua testa, diventa una sorta di videocamera che riprende lo spazio urbano che attraversa, come l’umanità che lo guarda o che semplicemente gli passa vicino. Noi guardiamo lui, la città e la gente attraverso i riflessi della sua testa, e alla sua riflessione cerchiamo, naturalmente, di rendere conseguente la nostra.
Raffaela Mariniello inquadra invece luoghi perfettamente conosciuti e riconoscibili delle città. Li riproduce con chiara nitidezza, lasciando al loro interno un elemento come dotato di una vitalità non controllabile. Quell’elemento diventa quindi il vero trade union fra noi e la realtà fotografata, come se fosse il punto di passaggio del nostro sguardo e della nostra capacità di trasferirci in quel luogo, di avvertirne la realtà.
Ancora diverso è invece il caso di Paolo Ventura, in cui il rapporto con il reale è perfettamente ricreato in una sorta di nuova dimensione, costruita in una scatola che diventa un micromondo perfettamente plausibile. Anche qui c’è una chiara volontà di sovrapporre il reale con il suo altro e parallelo surreale. Ma quello che è importante annotare non è tanto la verosimiglianza tra la ricostruzione e la realtà, quanto invece l’input narrativo che si innesta direttamente nella nostra percezione. Una narrazione che per quanto fantastica, è decodificata dal nostro sguardo, in perfetta continuità con l’ambiente in cui agiamo.
Anche le finestre di Roberto De Paolis, dimostrano la stessa volontà di sovrapposizione tra reale e surreale, cercando anch’esse di indurre ad una narrazione come sospesa. Quelle finestre su cui si fissa l’immagine di un interno con accadimenti interiori, rappresentano la possibilità di un entrare nella realtà, di penetrare all’interno delle sue apparenze superficiali.
Entriamo quindi nelle dimensioni di una realtà più vissuta che percepita, com’è il caso di Giorgio Barrera con la sua serie intitolata “Through the window “. Scene d’interno rubate, sguardi che si intromettono in situazioni private, ma che lasciano il sospetto che siano anche qui il frutto di una volontà narrativa, di una finzione che intende mostrare la realtà da una angolazione imprevista.
Lo sguardo che anche Francesco Jodice indirizza alle finestre, con il suo video “Rear window” è invece di natura diversa. Le persone riprese sono come accecate da una mascherina di luce e apparentemente impedite nello sguardo. Ma noi a nostra volta non possiamo vedere il loro volto. In questo gioco di impossibilità a vedere reciproco, c’è una delle radici profonde di tutto il lavoro di Jodice, che dietro il suo pretendersi come indagine e verifica sul campo, soprattutto in ambito fotografico, lavora sul limite stesso della rappresentazione del reale attraverso l’immagine.
Questa dimensione della realtà vissuta è anche quella che troviamo negli “Autoscatti” di Donatella Spaziani. Foto di se stessa realizzate in stanze di luoghi diversi, città in cui è stata per brevi periodi della propria vita. Rispetto alle foto di Barrea e al video di Jodice, qui il punto di vista è ribaltato. L’esterno è visto dall’interno e inquadrato attraverso le finestre. A fare da filtro visivo ed emotivo tra i due mondi, quello interno e quello esterno, c’è il corpo dell’artista, quasi fosse una specie di parametro esperienziale per il nostro sguardo.
“My Temporary Visiting Position From The Sunset Terrace Bar”, il video di Carlo Zanni che riprende in momenti diversi una parte di paesaggio visibile da un preciso luogo del pianeta, che in realtà è il montaggio di un cielo e di un profilo di case di un luogo diverso, è una vera e propria analisi fenomenologica della realtà attraverso l’immagine. Sembra una sorta di esperimento, ma ha invece una forte intenzione narrativa ed espressiva modulata sul parametro linguistico video più puro e semplice. Il lavoro è anche visibile in tempo reale on line, e dimostra quanto l’arte cerchi un rapporto con il reale tanto immediato, quanto differenziato dall’immagine così come è intesa oggi nel nostro ambiente supermediatico.
Raffaele Gavarro
tratto dal Catalogo della mostra “Zoom – Inside the Human Space“
Curatore: Raffaele Gavarro
Assistente al curatore: Chiara Nicolini
Artisti in mostra: Alterazioni Video, Giorgio Barrera, Rossella Biscotti, Roberto De Paolis, Paola De Pietri, Francesco Jodice, Domenico Mangano, Raffaela Mariniello, Guendalina Salini, Donatella Spaziani, Paolo Ventura, Carlo Zanni
Inaugurazione: Sabato 13 settembre ore 19:00
Periodo: Dal 13 settembre al 23 novembre 2008
Isola di San Servolo – Venezia
Ufficio Stampa: Studio Pesci


